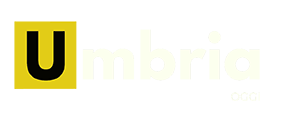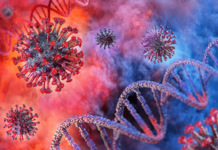di Stefano Ragni
pubblicato il 16 ottobre 2017 10:58:21
Con l’efficace titolo “Sia bello o brutto non so”, Sandro Cappelletto ha voluto ancora una volta onorare il suo prolungato impegno con gli Amici della Musica di Foligno, presentando una sua produzione di estrema efficacia, che ha visto la fattiva collaborazione della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli.
La frase è ovviamente di Giuseppe Verdi che, con la proverbiale sinteticità, commentava la stesura del suo Quartetto per archi, una piccola gemma che spicca nel firmamento della musica cameristica italiana del secondo Ottocento.
Nell’Oratorio del Crocefisso di Foligno, domenica pomeriggio, si è concretizzata una drammaturgia di piacevole discorsività, come è proprio del musicologo veneziano.
Frasi delle lettere di Verdi, pochi commenti, una narrazione di fatti e piccoli eventi che hanno segnato fin dall’inizio il singolare destino di una pagina anomala nella drammaturgia di un operista, ma segnata comunque dal graffio della grande firma.
Che poi Verdi il suo vero quartetto lo avesse già scritto lo sa chi ascolta quello del Rigoletto, “Bella figlia dell’amore” soprano e tenore, mezzosoprano e baritono coesi come quattro archi, un equilibrio quasi astratto di timbri e di incroci per una tensione acustica che sembra scrollarsi di dosso le parole per posizionarsi sul filo di una scansione quasi geometrica degli equilibri strutturali.
Poche, ineguagliabili battute, ma così caratterizzanti da finire in “Amici miei” di Monicelli, intonate dai quattro compagni di merende nel corso delle proverbiali “zingarate”.
Qui, nel sontuoso spazio barocco che è come uno sfolgorio per l’occhio, gli interpreti erano quelli storicizzati dalla prima esecuzione, che avvenne in forma privata nel 1873 a Napoli. Ieri, come allora, erano le prime parti della gloriosa orchestra del Teatro san Carlo, ed erano Cecilia Laca, Luigi Buonuomo, Antonio Bossone e Luca Signorini.
Il suono dolcissimo del primo violino, memore della grande scuola d’arco albanese, era di quelli che si trasmettono come un messaggio che arrivi personalmente all’orecchio di ogni ascoltatore, irrorando i leggii degli altri componenti di una patina particolarmente vellutata. Quattro professionisti coi fiocchi per una pagina di cui si parla molto e volentieri, ma che quando si ascolta risulta alla fine sottodimensionata rispetto al dibattito. Per Verdi non si trattò di farsi austriacante, ma di provare quelle trame contrappuntistiche che, stese negli ozi napoletani come un esercizio di penna, si sarebbero rivelate fatali nell’ultimo sipario del Falstaff.
Nella seconda parte di un concerto che sarebbe stato meglio spezzare con un intervallo, era una lunga silloge che Emanuele Muzio, unico collaboratore a cui Verdi abbia concesso il titolo di discepolo.
Si tratta di una stesura per quartetto dei temi favoriti della Luisa Miller, opera verdiana in cappa e spada, di cui si ricorda solo la romanza del tenore, qualcosa che ha a che fare con le serate di nostalgia. Il melodramma fu composto per il san Carlo di Napoli nel 1849, quando i piemontesi si facevano sconfiggere a Custoza e la storia veniva dall’amatissimo Schiller.
Trascrizione efficace, segno di deferenza di un allievo devoto, ma anche di uno strumentatore provetto. Anche qui il violino di Cecilia Laca svettante di morbidissime trame.
Applausi e defilamento del pubblico un po’ infreddolito dal rigido della sala.