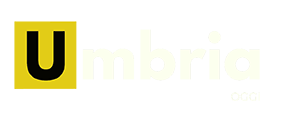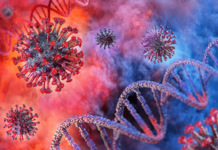Il tempo irrompe anche nell’aula del principe con la implacabile concretezza del bronzo della campana parrocchiale: nove rintocchi, più due, a cavallo del movimento conclusivo del sesto quartetto di Cherubini.
Ieri sera, al teatro Cucinelli, prima che il Quartetto di Venezia si gettasse nel vortico finale del capolavoro cherubiniano, gli archi hanno lasciato sfogare la voce del sacro, per poi ritornare alla solida coerenza di un concerto fulminante nella sua compattezza, per quanto convincente nella forma in cui è stato realizzato.
Sfiorare due capolavori con la solida concretezza che è propria dello storico Quartetto di Venezia è operazione propria di una stagione di concerti che coniuga semplicità, rigore ed efficacia in un’offerta quasi unica nel quadro delle iniziative italiane rivolte alla più fragile delle discipline artistiche, quella della musica da camera.
Quasi in sordina, con lo stile di chi sa offrire senza clamore, gli appuntamenti al Cucinelli seguono un percorso lineare, cooptando quel pubblico che è possibile attrarre in questa piccola Pienza umbra, raggiungibile solo in auto, il che comporta scelte consapevoli su come consumare la propria serata feriale.
Oltretutto, anche stavolta non si scherzava coi pezzi, due soli, ma solidi e densi, caposaldi di quel che la storia ha realizzato con la formazione ad archi di eccellenza. Pensieri astratti, organizzazione della forma, compimento di un percorso ad addensamenti progressivi, costringono l’ascoltatore a misurarsi con una delle più impegnative forme di decifrazione. Anche quando si tratta di accedere a una delle tappe più significative della via italiana al quartetto. L’ha realizzata Cherubini, l’arcigno fiorentino che Schumann volle paragonare a Dante, forse solo perché non conosceva Savonarola.
Dei primi due Quartetti di Cherubini il grande musicista e intellettuale tedesco se ne occupò nel 1838, pubblicandone una recensione della sua rivista: ne volle cogliere lo spirito aristocratico ed espresse tutta la sua stima. Ma in questo era stato preceduto da Beethoven che già nel 1823 aveva codificato la sua incondizionata ammirazione con un “L’amo e la venero”, frase che è stata apposta come titolo del concerto anche nei manifesti diffusi in città.
Ora, coi titoli bisogna andarci cauti, perchè vedendo nelle locandine la foto dei quattro veneziani, con alle spalle il palazzo ducale, quindi presumibilmente sulla piattaforma dell’isolotto di san Giorgio, si pensa subito a una bella canzone da gondola, magari come quella che il Lamberti dedicò alla storia “biondina”.
Salvo poi ritrovarsi al Cucinelli coi cannoni puntati da due autori scesi in campo con due poderose opere che, pur nella diversità dei valori espressi, hanno in comune la caratteristica della complessità.
Ora è ovvio che Cherubini era un operista, ma nei suoi sei numeri, e soprattutto in questo conclusivo, il sesto, appunto, il fiorentino ha enucleato quello spirito contrappuntistico che deve necessariamente essere alla base della forma del quartetto. Con in più una soluzione che sarebbe piaciuta molto a Beethoven: la ricapitolazione finale dei temi dei primi tre movimenti che ricompaiono nel quarto, il conclusivo.
 A questo punto, dopo il breve intervallo, speso a cercare di leggere un bel programma di sala, dal design elegantissimo, ma in cui non si decifra niente, stante le luci fioche e i caratteri a stampa adottati, ecco i veneziani portare in pedana l’op. 131 di Beethoven,
A questo punto, dopo il breve intervallo, speso a cercare di leggere un bel programma di sala, dal design elegantissimo, ma in cui non si decifra niente, stante le luci fioche e i caratteri a stampa adottati, ecco i veneziani portare in pedana l’op. 131 di Beethoven,
Qui la complessità, come si sa, prende anche le forme del bizzarro, dell’umoristico, mescolandolo al sublime con una capriccio estroversione propria delle migliori pagine di un Borges. E’ la “modernità”. Intuita, preconizzata, esposta da un visionario che aveva dimentica la commozione per innalzarsi nei livelli siderali della stratosfera del pensiero musicale. I veneziani non si sono fatti intimorire e hanno aperto la cassaforte con la logica di uno strumentismo eccellente, uno dei pochi accreditabili nella linea della indimenticabile lezione del mitico Quartetto Italiano.
Pubblico convinto e desideroso di ascoltare ancora qualcosa. Niente di meglio di un movimento di un quartetto di Schumann, tirato nel cerchio di un programma tra i migliori che si potessero realizzare.
Stefano Ragni